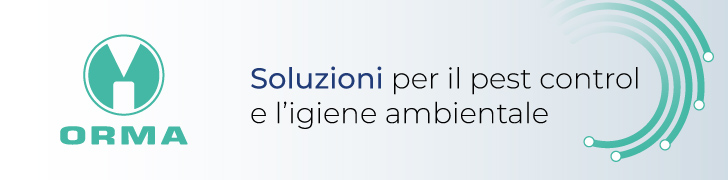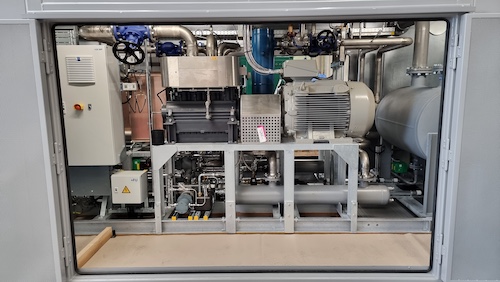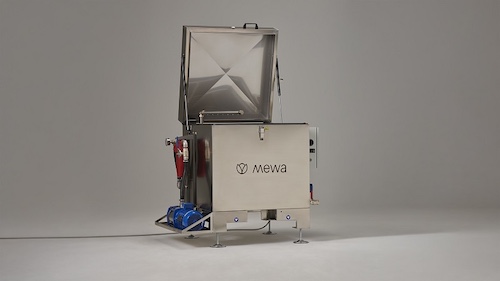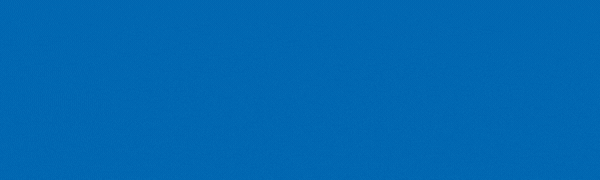Spazio ad alcune tra le migliori ricerche scientifiche applicate alle produzioni tradizionali e innovative di latte e latticini delle filiere vaccine e bufaline. Dalle colture tradizonali di caseificio all'utilizzo degli scarti per farne alimenti funzional,i a nuovi sistemi per evitare il rischio di pseudomonas.
Qual è lo stato dell’arte della ricerca scientifica applicata alle produzioni tradizionali e innovative di latte e latticini? Sono in corso diversi studi che coinvolgono la filiera vaccina e quella bufalina in cui sono coinvolti università e istituti di ricerca: l’ultima edizione di LattePiù ha dedicato una sessione ad hoc ad alcuni dei progetti più interessanti e innovativi.
Moderati dal Tecnologo Alimentare, Vittorio Zambrini, sono intervenuti professori e ricercatori coinvolti in attività di ricerca scientifica in questi ambiti.
Colture tradizionali di caseificio
A introdurre i lavori la docente Alessia Levante, Assistant Professor dell’Università di Parma, che ha esplorato il tema delle colture tradizionali di caseificio, che costituiscono “un’importante riserva di biodiversità microbica da caratterizzare e preservare”.
Rispetto alla necessità di studiare e descrivere sia la composizione delle colture artigianali che le dinamiche delle popolazioni microbiche presenti, la professoressa ha segnalato tre aspetti fondamentali.
Il primo è l’importanza di conservare la biodiversità di questi ecosistemi, e in questo ambito svolgono un ruolo fondamentale i consorzi così come i centri di ricerca e le università che si impegnano per preservare questa varietà di ceppi.
Il secondo aspetto di interesse è l’importanza di fornire la resilienza ai cambiamenti: se conosciamo la composizione delle dinamiche di questi ecosistemi possiamo prevenire i possibili effetti dei cambiamenti della materia prima, ad esempio quelli dovuti ai cambiamenti climatici.
Gli ecosistemi studiati sono sempre degli “ecosistemi complessi”, anche se il siero innesto presenta una maggiore diversità di specie al suo interno, mentre il lattoinnesto è generalmente più semplice nella sua composizione. In ogni caso, quello che è davvero affascinante di questi ecosistemi è la loro ricchezza di ceppi e biotipi.
La professoressa ha spiegato che gli ecosistemi vengono tradizionalmente studiati attraverso due approcci. Ci sono i metodi classici o culture-dependent, che sono quelli che i microbiologi utilizzano dalla fine dell'Ottocento circa, e che consistono nel far crescere le colonie microbiche su substrati nutritivi. Da qualche decennio sono però a disposizione dei ricercatori anche delle potenti tecniche culture-independent che permettono di identificare i microrganismi a partire dal DNA estratto dell’ecosistema, quindi senza bisogno di coltivare colonie microbiche.
La grande novità degli ultimi tempi è l’utilizzo combinato di questi due approcci che non si escludono a vicenda, ma anzi, si complementano e permettono di avere una visione davvero complessa della biodiversità presente nei sistemi.
La docente ha infine elencato alcuni importanti studi in cui questo approccio ha permesso interessanti scoperte. Ad esempio, un’analisi metatassonomica del microbiota di siero innesto utilizzato in Grana Padano, Parmigiano Reggiano e mozzarella ha mostrato che questi formaggi così diversi condividono un microbiota cuore, un insieme di specie condiviso. Altri studi hanno preso in esame il siero innesto utilizzato nella produzione del Trentingrana, la composizione microbica e il profilo peptidico di formaggi Asiago, e in un ultimo caso, la successione delle specie microbiche all’interno del siero innesto del Parmigiano Reggiano.
Usare gli scarti per farne alimenti funzionali
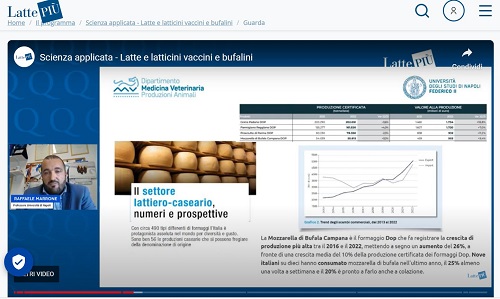
Il loro potenziale nutritivo, in passato, era trascurato, ma è invece potenzialmente molto interessante. Da qui l’idea di un progetto green per la valorizzazione economica degli scarti di lavorazione. Lo studio si è posto due obiettivi: in primis, identificare e caratterizzare ceppi di lattobacilli, isolati in particolare dal siero di latte di bufala, valutandone la sicurezza d’uso e le proprietà tecnologiche per la realizzazione di prodotti potenzialmente probiotici; secondariamente, preparare e caratterizzare ingredienti arricchiti di fosfolipidi a partire da siero di latticello di latte di bufala da utilizzare per lo sviluppo di prodotti di latte di bufala.
Al termine di una serie di test che hanno valutato con attenzione le proprietà antimicrobiche dei ceppi di lattobacilli sono stati selezionati 21 ceppi potenzialmente utili sulla base della valutazione dell’attività antimicrobica dimostrata e dei test per valutare l’attività emolitica, e in seguito saranno studiati per le loro proprietà antiossidanti.
Un approfondimento importante ha preso in esame quantitativo di lipidi sia nel latte che nel siero, ma anche nel latticello e nella scotta. Si tratta di liquidi che possono avere una grossa quantità di fosfolipidi e che possono sicuramente essere utilizzati in alimenti. I primi dati dimostrano che, rispetto al latte, nel siero ci sono più fosfolipidi e, cosa assai importante, i processi tecnologici del latte applicati non sembrano influenzare il profilo dei fosfolipidi.
Le conclusioni, ancora parziali ma già significative, ci dicono che il latticello, pur non mostrando il più alto contenuto di PLs, risulta essere il miglior scarto di lavorazione per la preparazione di ingredienti funzionali.
La “giusta” temperatura del provolone

Inoltre, il disciplinare del Provolone Valpadana DOP descrive come non debbano passare più di 60 ore dalla prima mungitura fino al momento della trasformazione del latte (salvo deroghe particolari).
Il lavoro dei ricercatori è stato quello di verificare la possibilità di aumentare la temperatura di stoccaggio del latte prima della trasformazione. Sono state quindi proposte tecniche di refrigerazione miste portando il latte a 10°C e a 12°C per 15 ore, per poi raffreddandola a 4°C per 45 ore, rispettando le 60 ore di cui si è detto poco sopra.
A quel punto sono state effettuate una serie di analisi microbiologiche sui campioni di latte forniti dai soci del consorzio, concentrandosi sulla valutazione della carica totale dei batteri e, successivamente, sulla valutazione di gruppi batterici che potevano essere definiti contaminanti, oltre che vere e proprie specie patogene. Su questi campioni sono poi state fatte analisi di metabarcoding.
In estrema sintesi si è verificato che, rispetto alla conservazione del latte, esiste un’assenza di differenze quali-quantitative fra i gruppi microbiotici nei campioni di latte alle due temperature considerate e una più elevata attività metabolica ed eterogenea all’aumentare della temperatura di stoccaggio.
In particolare, con riferimento al microbiota del formaggio Provolone, è stata verificata una maggiore biodiversità e ricchezza di specie per i campioni di Provolone prodotti con latte di stoccaggio a 12°C, dovuta molto probabilmente a microflora secondaria.
In ogni caso la dottoressa Vago ha spiegato come lo studio abbia dimostrato che non c’è stato alcun aumento di specie contaminate o patogene e che la presenza di microflora totale sia sempre rimasta entro i limiti previsti dalla legge. Per queste ragioni si è poi intervenuti modificando il disciplinare, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nel 2023, facendo ora riferimento ai 12°C come temperatura di conservazione. A dimostrazione di come questi studi abbiano poi impatti pratici molto importanti nelle attività. Questo aumento della temperatura di stoccaggio può avere anche un riflesso positivo sulla sostenibilità della filiera, sia per la riduzione dei costi energetici, che per una gestione più razionale della raccolta.
Per evitare la presenza del blu

Si tratta di bacilli dritti o leggermente curvi, che non producono spore, hanno un metabolismo aerobico, crescono facilmente nell’acqua, ma non sopravvivono a temperature superiori a 65°C. Tidona ha rimarcato come siano in grado di sintetizzare innumerevoli enzimi e possano metabolizzare sia composti a basso peso molecolare (aminoacidi, mono- e disaccaridi) sia molecole di grandi dimensioni. E alcune specie riescono a sintetizzare pigmenti idrosolubili che possono diffondersi negli alimenti, e sono anche in grado di formare biofilm particolarmente insidiosi e difficili da sanificare negli impianti e nelle attrezzature.
Rispetto ai pericoli di salute, nell’uomo la specie più comunemente associata a malattie è la Pseudomonas aeruginosa, che molto spesso provoca infezioni a seguito di lesioni dei tessuti, quindi in soggetti già con infezioni in corso o debilitati immunocompromessi. Non sono invece state registrate malattie derivanti dall’ingestione di alimenti contaminati.
Gli Pseudomonas hanno invece un impatto molto forte sulle proteine del latte, perché vanno a colpire preferibilmente le caseine. Possono causare problemi anche al latte alimentare come gelificazione e sedimentazione durante lo stoccaggio o la comparsa di gusti amari. I fenomeni di lipolisi possono colpire gli acidi grassi e causare fenomeni di irrancidimento o cambiamenti di aroma. I difetti di struttura sono riconducibili a problematiche di proteolisi, colpendo la betacaseina della mozzarella, causando un rammollimento della struttura.
Tra le alterazioni più insidiose da Pseudomonas ci sono quelle cromatiche. Molti ceppi sono in grado di sintetizzare pigmenti; alcuni di colorito giallo, altri verdi, ma soprattutto bluacei, come nei noti casi di mozzarella che hanno avuto un forte impatto mediatico. Gli agenti batterici contaminanti erano appunto ceppi di Pseudomonas fluorescens.
Cosa curiosa, la legge non prevede misure o specifici limiti nella presenza di Pseudomonas negli alimenti, con la sola eccezione della presenza di Pseudomonas rugginosa nell’acqua da imbottigliare. Quindi si deve ricorrere a misure di autocontrollo da parte dei produttori.
I ricercatori del CREA hanno svolto diverse analisi “sul campo” durante il processo della produzione di mozzarella, scoprendo che la prima fonte di contaminazione si trova nel latte crudo. Nelle analisi lo Pseudomonas si trova quasi sempre, da poche decine a qualche migliaio di cellule. La refrigerazione influisce negativamente: è proprio in questa fase che la componente batterica cresce maggiormente. Il dato positivo arriva, invece, nella fase di pastorizzazione, che elimina ogni traccia di Pseudomonas. Bacilli che purtroppo riappaiono nelle linee di rassodamento, quando entrano in gioco le acque di processo. È in questa fase che serve fare attenzione perché l’acqua di rassodamento non contamini il prodotto prima del confezionamento.
Positive le conclusioni: con una corretta gestione ambientale, quindi anche con pulizia e disinfestazione, il problema può essere evitato, anche perché i processi di pastorizzazione agiscono in maniera molto efficace nell’eliminazione di Pseudomonas presente nel latte crudo.
David Migliori