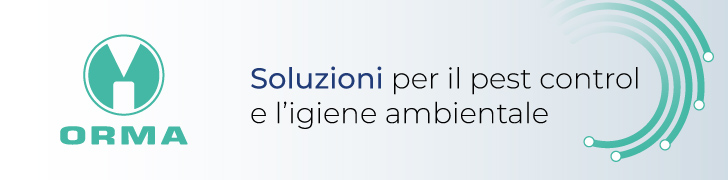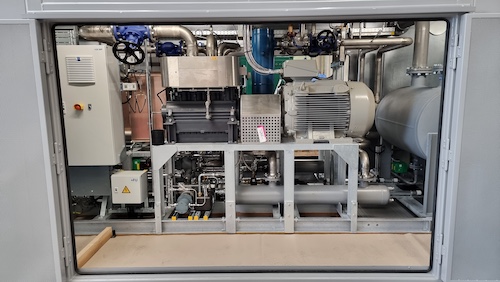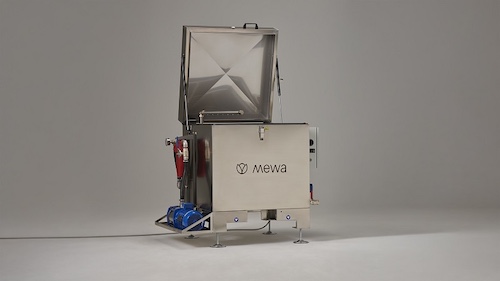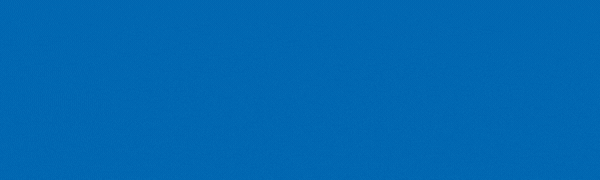Il lavoro dei disinfestatori è in costante evoluzione e, indubbiamente, ci sono circostanze che potrebbero complicarlo: mutano le leggi, diminuiscono le sostanze attive disponibili, gli adempimenti sono complessi e articolati e il mercato, infine, richiede maggiore attenzione, anche sotto il profilo delle certificazioni.
Di contro, vi sono fattori che dovrebbero o potrebbero semplificarlo: nuove strategie di lotta integrata, attrezzature sempre più “smart”, formulati più performanti e, non ultimo, software gestionali che diventano un ausilio sempre più importante, sia per la semplificazione dell’attività documentale che per la miglior pianificazione del lavoro.
Esistono, poi, fattori esterni, globali, di cui non sempre siamo in grado di considerare l’impatto: il clima e la globalizzazione. Cosa c’entrano questi ultimi con il nostro discorso? Come il cambiamento climatico e il trasporto di merci e persone possono influire sulle specie animali e vegetali presenti in un territorio e, in particolare, sul lavoro dei disinfestatori professionali?
Al riguardo, sempre più spesso sentiamo parlare di “specie aliene invasive” o di “specie alloctone invasive”.
Le “specie aliene invasive” sono organismi introdotti dall’uomo, intenzionalmente o accidentalmente, al di fuori del loro habitat naturale, che minacciano la biodiversità locale. Allo stesso tempo, costituiscono un rischio anche per le attività umane, come l’agricoltura o la tutela della salute.
Secondo il Regolamento (UE) n. 1143/2014, sono definite come specie esotiche invasive quelle il cui impatto negativo richiede un intervento coordinato a livello dell’Unione europea. Questi organismi possono includere insetti, piante, mammiferi e altri tipi di flora e fauna che, grazie alla loro adattabilità, trovano nei contesti antropici opportunità ideali per crescere e riprodursi.
In un mondo sempre più connesso, dove le merci vengono costantemente trasportate da un capo all’altro (ma anche in gli spostamenti delle persone sono certamente più semplici), è probabile che gli insetti più adattabili si diffondano e diventino “cosmopoliti”; l’Italia poi, nazione ospitale, risulta particolarmente vulnerabile a questo genere di colonizzazioni; pensiamo alla zanzara tigre (Aedes albopictus), alla cimice asiatica (Halyomorpha halys), al coleottero giapponese (Popillia japonica), alla cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis), al punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus), solo per citarne alcuni.
I danni derivanti, nella sola Italia, dall’introduzione della cimice asiatica in agricoltura nel 2012, sono stati ingenti, specialmente nel 2019. In quell’anno, le perdite stimate hanno superato i 740 milioni di euro, con alcune colture che hanno registrato perdite fino al 100%.
Dal punto di vista della salute pubblica, l’impatto delle zanzare AIM (Aedes Invasive Mosquitoes: negli ultimi anni sono state segnalate in Italia Ae. japonicus e Ae. koreicus, se dimenticare il rischio di introduzione della nota Ae. aegypti), provenienti da aree lontane dall’Unione europea, sta costituendo a livello globale una minaccia importante per la salute delle persone e degli animali, per la diffusione di arbovirosi. Il riscaldamento globale, inoltre, favorisce la diffusione di insetti invasivi dannosi per la salute umana e le attività economiche. L’aumento delle temperature estende l’habitat di vettori come zanzare e zecche, incrementando il rischio di malattie trasmesse all’uomo e agli animali. Inoltre, il cambiamento climatico amplia le aree di distribuzione di insetti nocivi per l’agricoltura, minacciando la sicurezza alimentare.
La tematica non è nuova in assoluto: già Charles Darwin comprese che alcune specie possono essere un pericolo, per esempio, per la biodiversità. Nel 1834, rilevò che il ratto grigio aveva di fatto avuto un impatto negativo sulle popolazioni di ratti preesistenti in Nuova Zelanda (a loro volta introdotte dai Maori qualche secolo prima).
Quando questi organismi si adattano a vivere in stretta vicinanza e rapporto con gli uomini, vengono definite “sinantropiche”. Le specie sinantropiche spesso sfruttano le modifiche ambientali apportate dall’uomo, come l’aumento delle temperature nelle città, la disponibilità di rifiuti come fonte di cibo, e la mancanza di predatori naturali.

Una nuova blatta in città
Un esempio classico di specie sinantropica è la blattella germanica, che infesta abitazioni, ristoranti, panifici, industrie alimentari, bar e locali pubblici sostanzialmente ovunque nel mondo; a ben guardare, non è un caso se tra le specie di insetti sinantropici cosmopoliti vi siano numerose blatte.
Le blatte – comunemente conosciute come scarafaggi – sono tra gli insetti più adattabili e resilienti del pianeta; riescono a colonizzare numerose nicchie ecologiche e, spesso, pur vivendo a stretto contatto con l’uomo, risultano “invisibili”. La loro presenza diventa manifesta quando, grazie alla loro veloce capacità riproduttiva, entrano in competizione alimentare e, costretti dalla fame e dalla mancanza di spazio, devono trovare nuovi punti di approvvigionamento trofico e di colonizzazione.
Ma gli scarafaggi sono tutti sinantropici e commensali dell’uomo?
L’ordine delle Blatte comprende 6 famiglie con 460 generi e oltre 4.000 specie; sono insetti cosmopoliti che vivono pressoché ovunque eccetto che nelle regioni polari e ad altitudini superiori ai 2.000 m. Delle oltre 4.000 specie presenti al mondo, solo una quarantina sono considerate sinantropiche o commensali dell’uomo e, di queste, solo 4 sono infestanti di interessa sanitario e merceologico in Italia: Blattella germanica (fuochista o mangiapane), Blatta orientalis (scarafaggio nero), Periplaneta americana (blatta americana), Supella longipalpa (blatta dei mobili).
Di fatto, quindi, in Italia vi è circa un decimo delle specie di blatte sinantropiche presenti al mondo. Potrebbero arrivarne altre? Potremmo, tra qualche anno, ritrovarci ad attuare strategie di lotta a blatte ad oggi ancora sconosciute?
Una domanda sorge spontanea: chi individua l’arrivo di nuovi insetti in un territorio? Molto spesso le Università, le quali ricevono campioni da cittadini curiosi e attenti e procedono con l’identificazione; negli ultimi anni, le app di riconoscimento “naturalistico” stanno contribuendo in questo genere di campionamenti. Alle volte, sono gli operatori del settore, come è successo nell’esempio sotto riportato.
Nella primavera del 2024, il sig. Luigi Cotumaccio, tecnico specializzato dell’impresa Iside S.r.l, fornitore professionale di servizi di pest management, svolgendo le sue normali attività di disinfestazione e monitoraggio presso il “CIS di Nola la città degli affari”, nota su alcuni supporti collanti impiegati per le attività di monitoraggio un’importante presenza di una blatta diversa da quelle solitamente rinvenute. Nel corso dei mesi, rileva che la stessa blatta è presente anche presso altri siti da lui seguiti: interporto di Nola (NA), interporto di Maddaloni (CE) e zona industriale di Carinaro (CE). Incuriosito, il sig. Luigi reperta alcuni campioni perché vengano identificati e – tramite la CEO dell’azienda per cui opera, Emanuela Ascione – gli stessi pervengono al dr. Francesco Nicassio, esperto del settore disinfestazioni e consulente di entomologia urbana e merceologica. Il riconoscimento delle blatte è stato effettuato dallo stesso dr. Nicassio presso i laboratori dell’Università degli Studi di Bari, per mezzo delle chiavi di riconoscimento dei generi di Blattidae, noti in Italia e nel resto d’Europa. Si è così stabilito trattarsi di una blatta che, sebbene capillarmente presente nei negozi di cibo per animali e nelle case di appassionati erpetologi, solo da pochi anni vive in natura in limitate zone d’Italia. Infatti, tra i campioni vi erano sia adulti (maschi e femmine), che neanidi e ooteche, consentendo di identificarli come appartenenti alla specie Shelfordella lateralis (Walker), conosciuta anche come Blatta lateralis o “Turkestan Cockroach”.
La blatta laterale è una delle specie più diffuse e allevate nel settore hobbistico, tra gli allevatori di animali insoliti, come rettili e anfibi o uccelli insettivori; vengono solitamente utilizzate come cibo vivo per sauri. La loro prolificità e facilità di gestione casalinga la rendono estremamente comune ma anche, nel caso assai probabile in cui alcuni esemplari dovessero sfuggire dall’allevamento casalingo, estremamente pericolosa e diffusiva. Questa, molto probabilmente, è stata la via di diffusione e di ingresso in molti paesi compresa l’Italia.
Originaria probabilmente delle zone desertiche e semi-desertiche dell’Asia medio orientale, è diffusa anche in Africa Nord-orientale, India e Asia centrale (AL-Houty, 2011). A partire dagli anni ’70, è presente anche negli Stati Uniti, Giappone e Messico, mentre solo negli ultimi anni appare anche a Cipro, in Turchia (Davranoglou et al. 2020) e nella penisola Iberica (Pradera & Carcereny, 2018).
Qual è però la situazione in Italia?[1] A seguito delle prime segnalazioni in Sardegna nel 2009 (Fois et al., 2009), ve ne sono diverse più recenti:
- in Veneto, sia nella città di Vicenza, che a Santa Maria di Sala (VE), negli anni dal 2018 al 2022;
- in Lombardia, a Galbiate (LC) nel 2022;
- in Lazio, a Roma e Pomezia nel 2022.
Francesco Nicassio Dottore forestale esperto in gestione integrata degli infestanti
Francesco Fiorente Dottore forestale esperto in gestione integrata degli infestanti