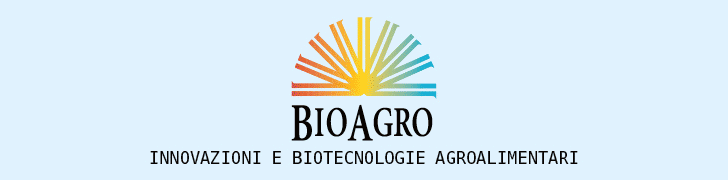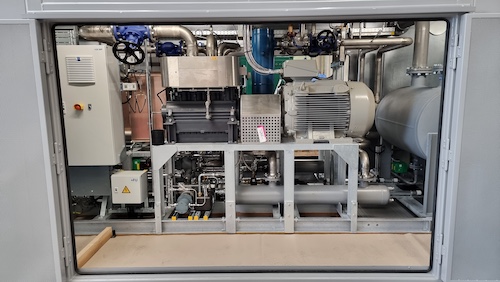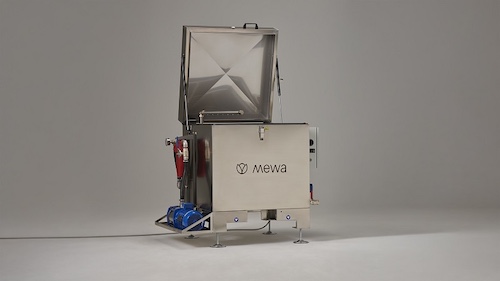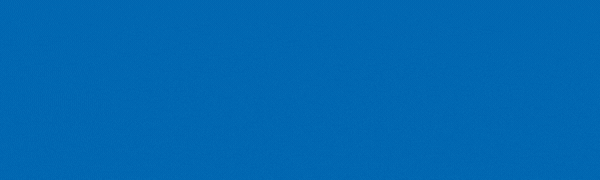Due parole latine caseum e formaticum, e una greca, toma: sono i termini alla base delle origini dell’attuale “formaggio”. Lontane nel tempo, non per modo di dire, perché Mario Alinei, dell’Università di Utrecht, che ha studiato l’origine e l’evoluzione etimologica dei termini, ha dovuto partire dal neolitico per giungere fino ai giorni nostri. Proviamo a fornire un sunto del suo interessante studio di Archeologia etimologica.
Una prima doverosa premessa fatta da Alinei è che, sul piano linguistico, l’origine di tutte le parole è, per definizione, collegata a un iconimo, ossia a una motivazione che mira a rappresentare la parola stessa. Un paio di esempi spiegano meglio di mille parole: automobile deriva dall’unione di mobile, “che si muove”, e auto, ossia “da sé, da sola”, e quindi fornisce subito la rappresentazione di qualcosa che si muove da sola, così come ferrovia, fornisce subito il concetto di una via di ferro. Nel caso del formaggio, come accennato all’inizio, il termine “formaggio” deriva dal latino “forma” e non a caso ancora oggi si dice “una forma di…”.
Quindi volendo andare alla ricerca delle origini del nome latino caseus/m e neoitalide cacio, così come dei tipi formaticum e toma dobbiamo considerare probabile che questi nomi abbiano avuto, in origine, un iconimo collegato alla tecnica di produzione del formaggio.
Da qui una conseguenza importante, che è la seconda premessa da cui partire: visto che è storicamente dimostrato che il formaggio è stato inventato durante il neolitico, periodo in cui il latino era utilizzato come lingua, è a queste lontane origini preistoriche che bisogna andare se si vuole provare a scoprire i primi utilizzi dei termini.
Le origini
Gli studi archeologici hanno scoperto che, al di fuori dell’Europa, la produzione di formaggio da bestie bovine era già intensamente praticata dai Sumeri: a riprova esiste un sigillo del periodo Uruk del tardo IV millennio che raffigura proprio delle stalle intervallate da caseifici.
L’invenzione del formaggio nel nostro continente si deve a quella che gli archeologi oggi chiamano la “Rivoluzione dei prodotti secondari del Neolitico”. In quel periodo, nel V e IV millennio a.C., furono introdotte in agricoltura oltre al formaggio e ad altri prodotti del latte, anche altre fondamentali innovazioni, come l’aratro e il concime. L’agro pastorizia era praticata da un paio di millenni, portata da innovatori medio-orientali e poi diffusasi progressivamente; la lavorazione del latte fu un’innovazione locale, poi diffusa, da uno o più focolai. Sono state trovate testimonianze archeologiche dell’antica produzione di formaggio in Italia, in Francia e in Svizzera; gli archeologi hanno portato alla luce alcuni degli strumenti con cui gli allevatori del Neolitico Finale fabbricavano il formaggio.
Per chi fosse interessato ad approfondire la materia Alinei consiglia la lettura del capitolo “Documenti dell’economia pastorale: la fauna e la lavorazione del latte”, nel volume Civiltà appenninica, di Salvatore Puglisi, che è considerato un classico dell’archeologia italiana, al cui interno si descrivono tra le altre cose anche i bollitori di ceramica di varia forma che i pastori usavano per fare il formaggio, assai simili a quelli usati fino a pochi decenni fa.
Comunque, quel che più conta per i nostri scopi etimologici, il ritrovamento dei reperti ha confermato che la produzione del formaggio era già presente nel V millennio a.C e che l’ambito culturale a cui appartengono è la cosiddetta cultura medio-neolitica di Chassey.
Caglio e coagulazione
Sul piano tecnico la scoperta innovativa è stata la cagliatura artificiale, ottenuta con l’aggiunta del caglio animale al latte dei mammiferi stessi. Da qui il formaggio come prodotto della somma: latte (di pecora, di capra o di vacca) + caglio.
Ma il latte cagliato, considerato in sé, non è legato alla produzione del formaggio, e quindi a una datazione neolitica. Il latte è un liquido organico, che le madri da sempre offrono ai propri neonati e, proprio nella forma di latte cagliato, riappare nel rigurgito dei piccoli. In più, nel Neolitico, i pastori e gli allevatori avranno spesso osservato il latte cagliato nello stomaco dei loro animali quando li macellavano. È ipotizzabile, secondo Alinei, che non esistesse ancora un termine specifico per indicarlo ma che esistesse invece l’idea e il concetto di “coagulo”, un fenomeno visibile in vari liquidi, e anche nel sangue.
L’innovazione neolitica che segna l’inizio della produzione del formaggio, dicevamo, non è quindi la scoperta del coagulo del latte come tale, bensì quella della produzione artificiale del coagulo, ossia la cagliatura del latte dei ruminanti domestici, mediante l’uso del quarto intestino chiamato abòmaso.
È ipotizzabile che l’idea di “farci qualcosa” con quel latte così stranamente raggrumato sarà venuta a qualche ingegnoso e sperimentatore allevatore neolitico che, avendo osservato che il latte conservato in un contenitore ricavato dallo stomaco di un animale era coagulato, lo avrà assaggiato e trovato gradevole al gusto. Fu certamente importante scoprire che l’abòmaso vuotato, essiccato e stagionato si prestava a essere conservato in casa e se ne poteva usare un frammento per cagliare la quantità di latte necessaria ogni volta che si doveva produrre il formaggio.
Il caglio/quaglio (termine utilizzato sia per indicare l’intero abòmaso essiccato che il singolo frammento) determina, dunque, il coagulo del latte, che consiste nella separazione del siero (con cui si fa poi la ricotta) dalla sua parte grassa, che si trasforma in una massa di grumi, base del formaggio, il cui nome più frequente è cagliata. Da cui si ottengono 3 tipi diversi di formaggio: 1) freschi, da consumarsi subito (in Italia stracchino, mascarpone, crescenza, robiola, giuncata, squacquerone etc.); 2) stagionati per alcuni mesi, e quindi semiduri e di media conservazione (provola, provolone, caciocavallo etc.); 3) stagionati più a lungo, e quindi duri e di lunga conservazione (pecorino, parmigiano etc.).
Passando alla ricerca etimologica, la base di partenza da cui partire, come accennato, è il riconoscimento dell’esistenza di una forma di latino già in epoca neolitica, che coesisteva con altri linguemi affini nelle altre aree italidi. Il fatto che nell’area germano-celtica non sia stata coniata una propria parola ma si sia adottato il nome latino caseus/m si spiega come conseguenza della diffusione dell’innovazione del formaggio proprio dall’Europa meridionale.
In Italia sono presenti quasi ovunque i continuatori degli affini italidi di coagulum e coagulare, nelle diverse varianti caglio/cagliare, cagghio/cagghiare, cagio/cagiare, cažo/cažare, quajjo quajjare etc.
Un tipo particolare comprende invece i derivati di prendere, nel senso di “rapprendere, rapprendersi”, che comprende i tipi preso, presa, presina, presura, presame, presore, impresa, ed è attestata in Piemonte, Trentino, Emilia e Romagna, Toscana, Marche, Corsica, oltre che in Francia, dov’è il nome standard – présure – del caglio. Ci sono evidenti prove che si tratta però di un’innovazione lessicale più recente di caglio, dovuta alla scoperta di un caglio vegetale, probabilmente una delle due erbe perenni, l’erba zolfina (o ingrassabue, caglio zolfino o presuola), il cui nome scientifico è Galium verum, o il carciofo selvatico, una compositae tubuliflore chiamata Cynara cardunculus.
Rispetto all’origine dell’umbro strignime, il riferimento può essere a numerose perifrasi, prese in prestito dal linguaggio comune, per descrivere l’azione del caglio sul latte: da prendere (nel senso di “rapprendersi”), generale nell’area di presura e famiglia, a stringersi (nell’area di strignime, ma parecchio più esteso), pigliare e rappigliare, rompere, unirsi, diventare/venire fisso.
È curioso notare una variazione in Corsica dove viene usato il termine aredu “caglio”. Questo dipende dalla tecnica usata nell’isola per la cagliatura del latte. Lì, infatti, l’abòmaso seccato e conservato in casa non viene usato prelevandone di volta in volta un frammento da immettere nel latte, ma versandovi del latte fresco, ogni volta che occorre. L’abòmaso seccato e utilizzato in questo modo diventa così uno strumento che dura a lungo e che viene addirittura passato da una generazione all’altra. Da qui è probabile che aredu sia da interpretare nel suo senso etimologico, cioè del suo iconimo di eredità, che nasce dalla sua origine da ad-heredium, arede “erede”).
Rispetto all’analisi fonetica, l’autore nota come in tutta l’area neoitalide i termini diffusi sono simili, come il nostro caglio, la versione meridionale quaglio, il sardo padzu, il francese cail, il provenzale calh, lo spagnolo cuajo, il portoghese coalho e così via. In tutta l’area, quindi, l’iconimo del nome del caglio è proprio il coagulo.
Volendo ulteriormente approfondire, la grande famiglia dei continuatori degli affini italidi di coagulum si lascia dividere in due grandi gruppi, ciascuno suddiviso in due sottogruppi, a seconda degli opposti esiti delle due sillabe coa- e glu. Quindi quelli che conservano il dittongo iniziale coa-, eventualmente mutandolo in qua- o in pa- e quelli che lo mutano in ca-. Nel secondo gruppo, quelli nei quali il gruppo interno /gl/ di coaglum passa a /yl/ e poi a /ly/ e /y/ e quelli nei quali passa, invece, prima a /gy/, poi a /g/ o a /ž/ o a /ôc/ (in finale), e infine a una sibilante.
L’analisi semantica
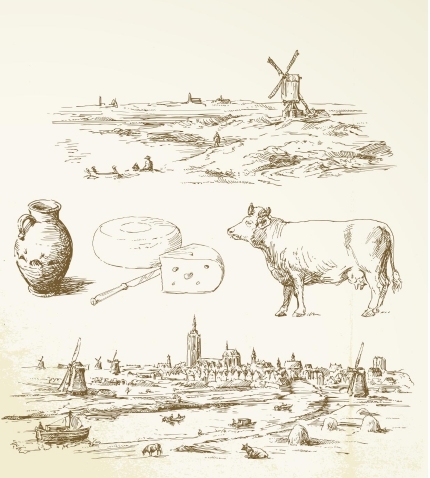 I continuatori di coagulum hanno dato al termine tre diversi tipi di significati.
I continuatori di coagulum hanno dato al termine tre diversi tipi di significati.
1. In un primo caso indicavano l’intero quarto stomaco dei ruminanti, cioè l’abòmaso stesso, da cui si ricava il caglio; il nome quaglio è ripreso anche nella letteratura zootecnica.
2. Ci sono poi quelli che designano il frammento di abòmaso disseccato.
3. Infine, quelli che designano il risultato finale del processo, di solito chiamato più precisamente, latte cagliato o cagliata.
L’autore segnala un ulteriore uso del termine per indicare in alcuni casi il formaggio stesso. Che il caglio finisca per indicare il formaggio non deve stupire se si pensa che per le persone che si occupano della produzione casearia è del tutto naturale che svanisca la differenza fra “latte cagliato” e “formaggio fresco”. Nella realtà il latte cagliato è già una sorta di formaggio fresco.
Antinori utilizza una ricca documentazione storica per avvalorare la tesi dell’identità lessicale fra caglio e cacio. Lo fa partendo dall’area lombardo-emiliana e mostrando evidenze della corrispondenza tra i nomi del caglio, del cagliare, e della cagliata da una parte, e quello del verbo caciare dall’altro. La conclusione a cui giunge è che il termine Cacio /kašo/ altro non è che la variante sorda del kažo/ caglio/formaggio lunigiano-garfagnano-alto versiliano e tosco-emiliano, che può essersi formata sia direttamente da caôc, sia, più probabilmente, da cagio, per quello che chiama un ipercorrettismo di una forma tosco-emiliana.
Da Coagulum a Caseum
Il lungo periodo preistorico analizzato può essere per comodità diviso in tre differenti fasi.
1. In una prima fase neolitica ci sarebbe stata la scoperta e la successiva diffusione in tutta l’area italide della cagliatura artificiale del latte per produrre questo nuovo alimento. La grande diffusione di formaggi e l’analisi linguistica spingono a pensare che l’origine sia stata prima in Francia, più precisamente nel Midi, un’area montuosa particolarmente adatta alla transumanza. Quale sarà stato il primo formaggio fresco? Probabilmente sarà stato un pecorino o un caprino perché la transumanza estiva riguardava soprattutto gli ovicaprini. Dalla Francia meridionale, l’innovazione si è poi diffusa sia in Iberia che in Italia, aggiungendo quindi, ai precedenti significati del tipo coaglu e dei suoi affini italidi, il senso di “latte destinato a diventare formaggio”. Questa prima fase sarebbe quindi consistita nella semplice diffusione culturale, senza altre ripercussioni, oltre a quelle semantiche, dell’innovazione del caglio artificiale del formaggio fresco, designata con lo stesso nome del “coagulo” dei liquidi organici.
2. In una seconda fase, del Neolitico (V millennio) e all’inizio del Calcolitico (IV millennio), la produzione del formaggio semiduro e duro iniziata in Francia meridionale si diffonde anche altrove. È la cosiddetta cultura di Chassey che porta in Italia l’innovazione culturale del formaggio semiduro e duro, che segue quella del formaggio fresco. In Italia settentrionale e centro occidentale, in Toscana, Sardegna e Corsica si diffonde il nome cagiu/caciu e variazioni.
Successivamente, l’innovazione arriva nell’area lombardo-emiliana di Lagozza, dove si sviluppa maggiormente la produzione del formaggio semiduro e duro. Per designarlo si conserva il nome del caglio e del formaggio fresco cac/cago/cažo/ e variazioni. Quando la cultura di Lagozza si diffonde nel resto della penisola, con essa si diffondono anche l’innovazione – e il nome – del formaggio semiduro e duro, cacio. E, poiché nel Centro-Meridione della penisola l’allevamento era prevalentemente ovino, il cacio in quest’area nasce pecorino. Nel Centro-Sud e nelle isole, quindi, il tipo cacio, ormai nettamente distinto dal suo antenato quajjo quagghio e le sue variazioni coagulo, caglio e anche con il nuovo significato di “formaggio semiduro o duro”, subirà i normali processi di adattamento.
3. Con la terza fase arriviamo all’età dei metalli, in particolare nel Bronzo, quando l’egemonia economica e culturale passa al Centro-Sud, e la grande cultura dell’Appennino comincia la sua espansione, che porterà a Villanova e a Roma, il tipo cacio risale, come cavallo di ritorno, a Nord. E nasce la discrepanza fra gli esiti lombardo-emiliani in /g/ o /ž/ dei continuatori di coaglare, caciare, e quelli in /z/ per il nome del caciaio/casaro, che solo in alcuni punti conserva l’esito originale, mentre quasi ovunque è divenuto /kaz’er/, con la sibilante sonora. È nelle età dei Metalli, insomma, che nascono il casaro e la casera padani (con la s sonora) “moderni”.
Più tardi ancora, all’inizio dell’età storica, nel Latino scritto ed elitario dell’epoca classica il tipo lessicale orale, ormai lontano dal coagulo e dal caglio originale, identificato con il formaggio stagionato, verrà ricostruito, in forma grafica, come caseus.
David Migliori