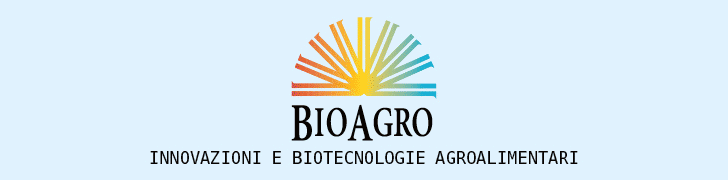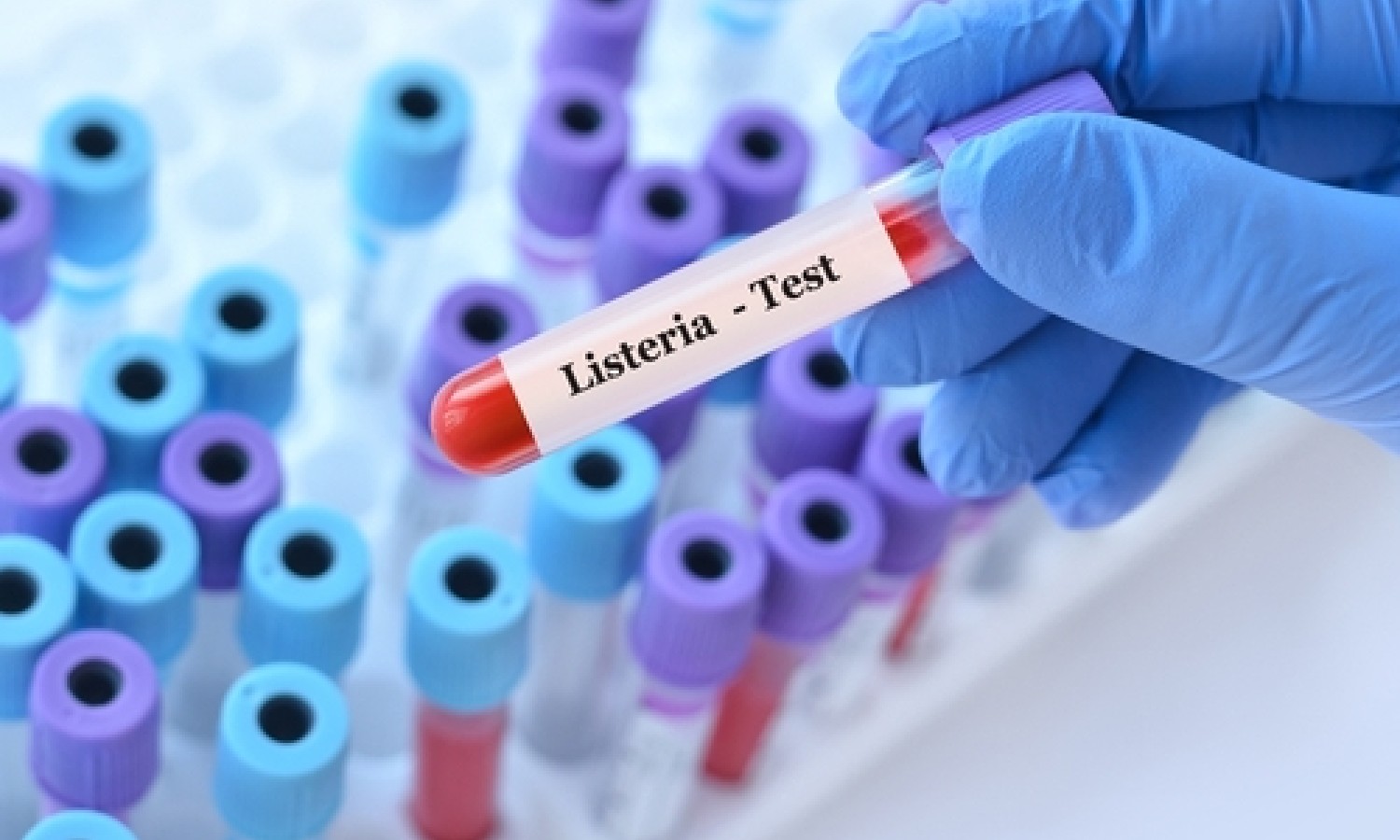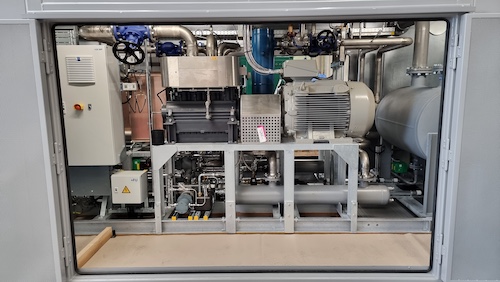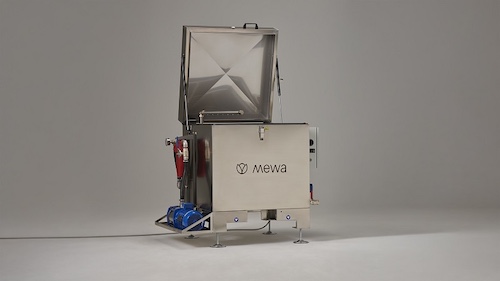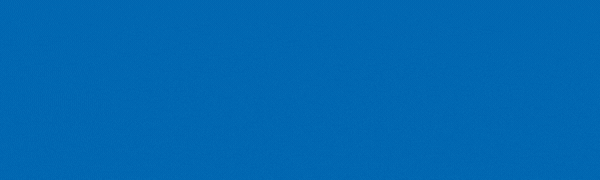C’è chi dice che la denominazione d’origine sia un’invenzione, frutto di una brillante operazione di marketing. Questo però non è quello ci dice la scienza o, meglio, le scienze degli alimenti, almeno nel caso dei formaggi DOP a latte crudo.
Posti sotto la lente di ingrandimento, o ben più potenti strumenti analitici, di microbiologici, chimici ed economisti degli alimenti, 4 formaggi DOP italiani sono stati il focus del progetto PRIN (progetti di ricerca rilevante interesse nazionale, ndr), “Formaggi con Denominazione di Origine Protetta (DOP) e non: interazioni tra preferenze e consumatori e cheese-omica”. I risultati del progetto, durato 3 anni, sono stati presentati in un evento conclusivo in cui i ricercatori degli atenei coinvolti, Università di Parma come capofila, Università di Torino e Università di Bari, hanno tirato le fila dei complessi esiti delle rispettive ricerche.
I 4 formaggi, scelti come rappresentanti delle diverse aree di Italia (Parmigiano Reggiano DOP, Roccaverano DOP, Caciocavallo Silano DOP), o a essa trasversali (Grana Padano DOP) sono stati confrontati con prodotti simili, ma senza marchio, disponibili sul mercato.
Il confronto è stato fatto all’assaggio, con analisi sensoriali codificate, fatte da esperti assaggiatori ONAF, e con analisi meta-omiche, in grado di rilevare i metaboliti volatili associati all’aroma e al gusto, e il microbiota e i suoi geni, probabilmente responsabili della loro presenza/quantità.
Il tratto comune dei 4 formaggi scelti è la produzione a partire da latte crudo e la scelta dei produttori di attenersi a un disciplinare di produzione. Con tecnologie simili, ma senza l’obbligo di rispettare specifiche indicazioni, si ottengono formaggi cosiddetti “tipo”.
I prodotti a marchio DOP hanno generalmente un prezzo più alto, ma è lo stesso marchio a rappresentare uno dei motivi per il quale il consumatore è disposto a spendere di più. La complessa correlazione statistica tra l’incredibile mole di dati generata dai vari ambiti di ricerca di questo progetto, rivela però che il consumatore non sceglie solo per ragioni di affetto verso una tradizione o un territorio, o perché indottrinato dal marketing dei marchi DOP.
Nella maggioranza dei casi, infatti, la preferenza al palato risulta infatti saldamente connessa a specifici composti che sono il risultato dell’attività di specifici microrganismi, che sono specifici solo dei formaggi DOP.
Nei formaggi non DOP, una maggior eterogeneità di scelta delle materie prime e delle tecnologie, si riflette in una maggior variabilità tra i microbioti presenti, che si caratterizzano per una minor ricchezza funzionale: sono meno coinvolti nelle vie metaboliche da cui derivano gli aromi che il consumatore avverte come migliori.
E guarda caso, i formaggi non DOP che sono risultati più graditi all’analisi sensoriale, sono quelli con un profilo microbico più simile al corrispettivo formaggio DOP. Sembrano essere quindi i microrganismi i principali responsabili della classificazione dei formaggi analizzati come buoni o meno buoni.
Nel caso dei formaggi DOP, tali microrganismi derivano dal latte crudo e/o dell’innesto naturale e rappresentano il legame con il territorio, un legame che il consumatore è in grado di scegliere e apprezzare non solo grazie a un acronimo in etichetta. Produrre secondo DOP è una scelta che deve poter essere valorizzata. Consumare prodotti DOP è un’opportunità che può essere colta con trasparenza e consapevolezza.
Benedetta Bottari
Professore Associato Microbiologia degli Alimenti Università degli Studi di Parma